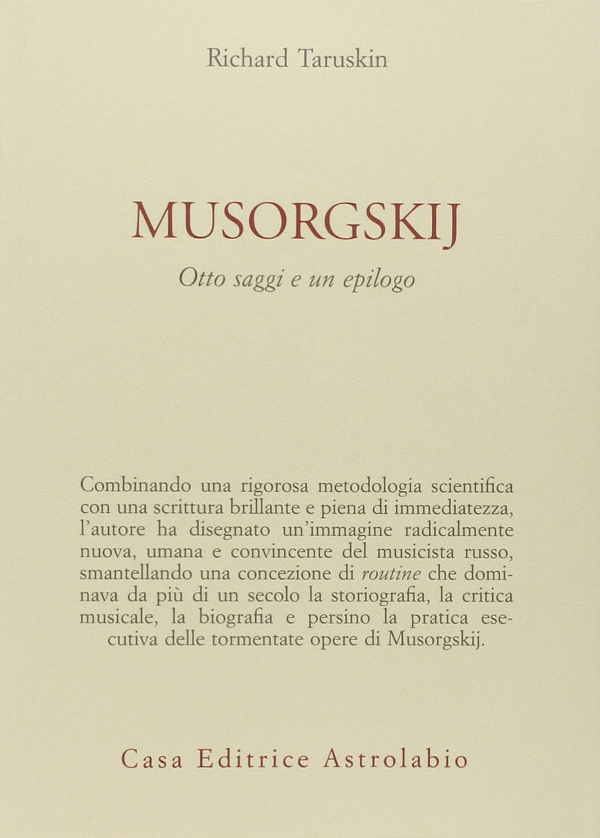La lentezza del rigore
di Giuseppe Guggino
Richard Taruskin
Musorgskij
Otto saggi e un epilogo
387 pagine
Casa Editrice Astrolabio, Roma, 2014
ISBN: 978883401671
Se dalle lezioni americane di Calvino si trae qualche buono spunto sulla rapidità, per converso, questo libro dell’americano Richard Taruskin è una meravigliosa ed edificante lezione sulla lentezza; e non certo per la qualità della penna - ché è di primissimo ordine e sempre piacevole - ma perché è praticamente impossibile leggerne più di quattro pagine senza che la curiosità del lettore sia stimolata ad un ascolto o riascolto di qualche cd, alla ricerca di qualche spartito (oltre i numerosissimi esempi musicali proposti nel volume) per mettersi al pianoforte e confrontare, insomma, è impossibile concludere un periodo che non si sia sollecitati alla divagazione, al pensiero. Sicché in questa gigantesca mole labirintica di osservazioni, ipotesi, argomentazioni, conclusioni è bello darsi appuntamento serale col pensiero musicale (per un bel numero di serate!) e lasciarsi condurre nell’universo operistico russo dal Virgilio più erudito e acuto che si possa immaginare.
Se ancora negli anni ’80 un pianista-musicologo del calibro di Glenn Gould (sulla cui intelligenza musicale nessuno oserebbe avanzare sospetti) cadeva nel solito luogo comune su Musorskij, considerandolo «uno dei compositori tecnicamente più sprovveduti della sua epoca», si possono facilmente comprendere le ragioni per le quali nel 1993 il massimo degli studiosi musorskiani decise di riunire e accrescere questi Eight Essays e darli alle stampe. Abbiamo traslitterato Musorskij intenzionalmente senza la “g”, proprio perché è lo stesso Taruskin a chiarire come lo stesso compositore si firmava certamente senza la “g” fino al 1862, anzi talvolta per gli amici anche “Musor” ironizzando sul significante che, tradotto dal russo, sarebbe “spazzatura”, e scegliendo solo dopo la lezione oggi corrente; comunque sia, accettando anche il vezzo della “g” aggiunta, si deve aver cura che la sua pronuncia sia muta e l’accento tonico cada sulla prima u.
Fugata la prima fonte di incertezza sul cognome, inizia il lavoro di scrostatura o quantomeno di rilettura critica del luogo comune costruito a partire dagli scritti di Vladimir Statov, il letterato critico musicale semidilettante che esercitò il ruolo – diremmo oggi – di “ideologo” della kučka dei Cinque, ossia del gruppo costituito negli anni ’60 da Balakirev, Cui, Borodin, Musorskij e Rimskij-Korsakov. Certamente la conoscenza Stasov era diretta e approfondita, ma la lettura dell’uomo e del musicista era filtrata in maniera diottrica dal ruolo dell’ideologo, nell’egemonizzare le opinioni nel gruppo; se infatti al ritratto storico-critico di Stasov, per comparazione, si accosta il ritratto coevo delle memorie del Conte Arsenij Arkad’evič Goleniščev-Kutuzov, poeta lontano parente di Musorskij (perché non era un ubriacone, ma pur sempre un esponente di una dinastia nobiliare decaduta) che con lui condivise anche l’abitazione per quattordici mesi e con il quale ebbe rapporti di massima franchezza non interferiti dall’esigenza di dover necessariamente ricevere approvazione, si comprende come il primo testimone sia certamente parziale e non del tutto attendibile. Gli ideali diremmo oggi “progressisti” o “populisti” del Musorskij sono così subito circoscritti, prima ancora dell’analisi dell’opera (anzi nello spartito della Fiera di Soročinscy si riscontra anche un modo poco progressista di chiamare gli ebrei, poi addomesticato dai curatori delle edizioni a stampa); così come anche il mito fauvista è sfatato dall’esame dei manoscritti di alcuni pezzi da salotto per canto e piano, redatti sempre con una grafia accuratissima di chi non agisce sotto impulsi estemporanei. Ed è proprio lo studio dell’evoluzione stilistica della linea melismatica da protjažnaja nei Lieder da camera, dalla raccolta La camera dei bambini degli anni ’60 fino all’estremo Senza sole della fine degli anni ‘70, costante interpunzione della parabola musicale del nostro, a smontare l’assioma tutto stasoviano dell’appannamento della vena creativa negli ultimi anni di vita.
Il percorso che i saggi di Taruskin ipotizzano, vagliano e comprovano con un metodo, rigore argomentativo e una serietà ammirevole, certificano un progressivo “arretramento” (parola corretta solo se il metro del progresso è quello dell’estetica kučkiana) dalla parola declamata nell’ideale dargomyžskiano, verso il ritorno a numeri chiusi e “melodie razionalmente giustificabili” dell’establishment (il tanto avversato Anton Grigorevič Rubinštejn e il deriso Aleksandr Nikolaevič Serov); le parentesi di compartimentazione di questo percorso, entrambe gogoliane, entrambe incompiute e non orchestrate sono il giovanile primo atto della commedia Il matrimonio (di cui esistono due diverse stesure) e quello che doveva grossomodo corrispondere al secondo atto della Fiera di Soročinscy, l’ultima opera pervenuta allo stadio di abbozzo in spartito (orchestrata da Cui, prima che da altri).
A proposito di Serov, destinatario del pamphlet musicale per canto e piano Raëk composto su pressione di Stasov (che, di fatti, è dedicatario della composizione) si deve una delle più illuminanti rivelazioni degli studi di Taruskin; si tratta infatti dell’unico compositore russo misuratosi con Rogneda nel dramma di argomento storico prima del Boris Godunov che, sebbene avversato da Musorskij in ossequio ai voleri di Stasov, tacciato di wagnerismo, è probabilmente l’unico vero precursore dell’orizzonte estetico musorskiano e certamente quello con più elementi di contatto rispetto agli altri quattro della kučka. Purtroppo non esistono incisioni né dell’opera storica Rogneda, né della verista Forza nemica, quindi ci si deve accontentare degli spunti di Taruskin tutti dimostrati con confronto tra i diversi spartiti; esiste invece un’incisione della biblica Giuditta che all’ascolto si rivela di accecante bellezza: già solamente questo varrebbe la gratitudine del lettore.
Sarebbe praticamente impossibile elencare le ulteriori valide ragioni per perdersi in questo labirinto, tanto numerosi sono gli spunti e la brillantezza con la quale ognuno di essi è sviluppato; ci si limita a segnalare lo studio comparato della scrittura corale del terzo atto di Oprichnik di Čajkovskij e del veče dalla Pskovitjanka di Rimskij a quella omofonica (recensita come “troppo ordinata” da Rimskij) nel terzo atto del Nižegorodcy di Napràvnik per capire quanto sia utile alla comprensione della grandezza musorskiana un’accurata collocazione della sua opera nel contesto storico e critico.
Le vicissitudini del primo e secondo Boris costituiscono il cuore del volume e rappresentano il vertice della compiutezza critica taruskijana secondo la quale le due redazioni dell’opera, quella del 1868 e 1871-’72, sarebbero due opere marcatamente differenti a causa di un graduale cambio di prospettiva nella mente del compositore; in effetti lo studio dimostra come il rifiuto da parte della Commissione dei Teatri Imperiali riguardava esclusivamente l’assenza del personaggio femminile (smontando tutto il castello della storiografia musicale, dimostratosi falso, alla luce dei documenti e delle testimonianze nei vari epistolari vagliati) e sarebbe stata sufficiente l’aggiunta del solo duetto del cosiddetto atto polacco a garantire il permesso alla rappresentazione. Invece la revisione di Musorskij è molto più radicale rispetto alle richieste, perché nell’atto polacco si innesta anche tutta la scena della fontana (già pensata prima del rifiuto ma non realizzata), il taglio totale del quadro di San Basilio e il nuovo quadro conclusivo nella foresta di Kromy, più un’innumerevole quantità di riscritture di interi passi, oltre che qualche piccolo taglio. Taruskin, che ritiene “definitivo” l’ultimo Boris, osserva inoltre come soltanto in quella versione si realizza una struttura palindroma all’interno dell’opera (e l’osservazione, abbastanza evidente a guardare la distribuzione delle scene, si rivela invece nella sua lampante genialità!) per cui l’interpolazione in essa del quadro di San Basilio è fuori luogo, così come tutta l’attività di collazione ipertestuale operata delle varie edizioni critiche di Lamm-Asaf’ev, Reilly e David Lloyd-Jones giacché come mostra il saggio e gli studi paralleli di Robert Oldani, dal confronto di passi identici riscritti tra le due versioni (quindi non solamente un lavoro di taglio e cucito) c’è un mutamento dell’orizzonte estetico di riferimento dal declamato della prima versione alla melodia modellata sulla parola nella seconda: con buona pace di Statov, nella seconda versione si fa più marcato il distacco dalla fonte puskiniana (i versi dell’atto polacco sono riscritti e lì la scrittura ricorre ai numeri chiusi sia nel boudoir di Marina, sia nella scena della fontana!) e, in ultima analisi, l’autonomia di Musorskij dalla kučka. Ma la grandezza di questo approccio metodologico che, pur partendo da considerazioni filologiche, non è condotto da un filologo bensì da un musicologo i cui orizzonti letterari e, più in generale culturali, sono sconfinati consente di guardare il “problema del tono” dell’opera scollando gli occhi dal dettaglio sul foglio per accorgersi come il ripensamento dell’opera, prima ancora che di orizzonti estetici, è ideologico in chiave tutt’altro che positivistica! E infatti la chiave di lettura è totalmente inedita per la storiografia musicale del regime sovietico, che mai sarebbe riuscita a cogliere minimamente quella che, alla lentezza del rigore di Taruskin, pare un’ovvietà. Non patendo gli ammorbamenti filologici, il saggio non ha che parole di gratitudine per le due riorchestrazioni di Rimskij, capaci quantomeno di consentire al capolavoro una sopravvivenza e una circolazione con minori pasticci fra versioni di quanto non si faccia oggi, forti di una maggiore conoscenza dell’originale alle fonti.
Di particolare curiosità è lo studio sui motivi di derivazione popolare, dove si scopre che l’inno del popolo nell’incoronazione "Slava!" proviene in realtà da un ingenuo canto popolare catalogato a fine del ‘700 come melodia natalizia e già inglobata a ‘mo di omaggio per il committente Razumovkij nello scherzo del quartetto Op. 59, n. 2 di Beethoven, poi travisato e usato come inno, oltre che nel quadro di Novodevičij, in un’opera di Rubistein (dopo il Boris: evidentemente non l’aveva proprio voluto ascoltare!) e nell’ultima opera di Rimskij.
Il saggio su Chovanščina è una lezione di storia; imperdibile. È chiaro come l’opera che, con la Fiera, occupò in parallelo gli ultimi anni di vita del compositore, se solo fosse pervenuta al completamento della stesura, sarebbe stata di livello tale per cui, al cospetto, il gigantesco doppio Boris avrebbe fatto la figura dell’opera di apprendistato.
Nel pessimismo di Musorskij in cui la passione civile di Taruskin spera di non voler rivedere le sorti politiche della Russia con la postfazione scritta all’indomani della caduta del muro di Berlino, si ricade con la postfazione all’edizione italiana, scritta in concomitanza all’inizio della guerra ucraina dei nostri giorni. Se in questa edizione italiana fresca di stampa la penna di Taruskin si rivela felice quanto le sue intuizioni musicologiche il merito è delle traduzioni di Anna Giust e Livio Agresti, oltre che della grande cura editoriale dell’Astrolabio (in un’immensità di citazioni, note, rimandi le sviste di battitura si contano sulle dita di una mano: “uni” mancante a pag. 13, una “t” saltata a pag. 119 ma ripresa con una “t” di troppo nell’indice e una parentesi mancante a pag. 356) straordinariamente meritoria per questa pubblicazione e, più in generale per la collana di traduzioni musicali “adagio”. Si spera che l’esito felice di questi otto saggi possa condurre presto alla traduzione di Oper and Drama in Russia dello stesso Taruskin; fino ad allora gli otto saggi costituiranno certamente quanto di più interessante si possa leggere in italiano sull’opera russa.